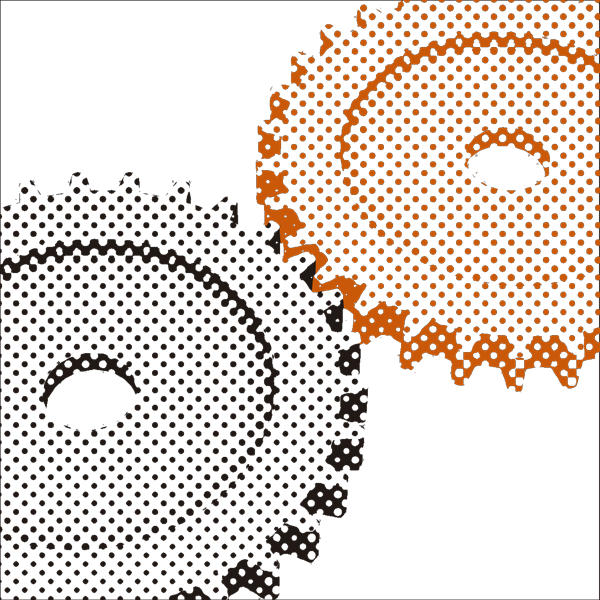Augusto Graziani è stato parte di una stagione irripetibile del pensiero economico italiano: un intellettuale impegnato e a tutto tondo, che male si farebbe a ridurre a una qualche dimensione ‘profetica’. Graziani, con Napoleoni, Sylos Labini, Lunghini, Caffè, Garegnani, Ginzburg, Vianello, De Cecco e pochi altri, fa parte di una generazione che, mentre si apriva ai contributi del pensiero economico anglosassone, lo faceva in modo critico e aperto, proponendo una riflessione originale. Una ‘tradizione’ di cui andare orgogliosi, dove la simbiosi tra la storia dell’economia politica e dell’economica, da un lato, e lo sviluppo di schemi teorici alternativi, dall’altro, andavano di pari passo con una visione dell’economia come parte di una scienza sociale critica. Il dibattito teorico veniva integrato e prolungato nell’intervento diretto sulle questioni di politica economica, senza che vi fosse iato alcuno e mai scivolando nell’astrattezza. Non si temevano i contrasti, anche aspri, ma la polemica si manteneva sempre ai massimi livelli, senza mai degenerare (come sovente oggi) a rissa da cortile. Non lascia eredi, piuttosto un compito: quello di reagire a questa era di decadenza nel pensiero economico italiano, sfuggendo alla tenaglia tra l’importazione di una teoria economica apologetica e il corto circuito cui si condannano i filoni marginalizzati.
Graziani nasce a Napoli nel 1933, e si laurea nel 1955 con Di Nardi. Studia alla LSE di Londra con Lionel Robbins e ad Harvard, dove incontra Leontief e Rosenstein-Rodan. Ordinario a 27 anni, ha insegnato a Catania, Napoli, Roma; collabora con Rossi Doria al Centro di Specializzazione di Portici, e con Compagna a Nord e Sud. Benché la sua prima riflessione sia stata spesso caratterizzata come tradizionale, le cose non stanno così. Lo testimoniano due libri. Il primo, nel 1965, è Equilibrio generale e macroeconomico, dove Graziani si smarca dall’attacco alla teoria neoclassica per la fallacia logica nella teoria del capitale e della distribuzione: in quel testo ‘difende’ l’equilibrio generale walrasiano istantaneo, criticando i modelli macroeconomici di crescita proporzionale. Contesta però le assunzioni della teoria ortodossa, che vede l’economia e la società popolate da consumatori sovrani e con tecnologia esogena: un mondo dove la moneta non può che essere neutrale. È un punto che anche il Graziani ‘circuitista’ ha sempre confermato, resistendo a ‘matrimoni forzati’ tra Sraffa e Keynes. A suo giudizio i critici italiani del pensiero neoclassico avrebbero fatto il passo falso di impegnarsi in una estenuante e alla fine controproducente ‘caccia all’errore’, con risultati immediati e fatali. La critica deve essere ai presupposti di base, a partire da visioni ideologiche diverse e da ricostruzioni alternative del processo capitalistico.
È qui che già nel primo Graziani soccorre il contenuto del secondo libro, del 1969: Lo sviluppo di una economia aperta. La competitività non dipende né dalle dotazioni fattoriali né dai vantaggi comparati. La scelta di aprirsi al mercato internazionale impone l’adozione di certe tecnologie, che a loro volta determinano il ritmo della produttività e la quantità di lavoro occupabile: nel settore ‘avanzato’ è possibile godere di (relativamente) alti salari, mentre la forza-lavoro occupata nelle imprese che non producono per l’estero è intrappolata in un circolo di bassa produttività e bassi salari. Anche il Graziani successivo è sfuggito alla falsa alternativa tra liberoscambismo astratto e protezionismo, per sottolineare come l’economia internazionale è retta da commercio manovrato e governo politico dell’accumulazione.
Negli anni Settanta il pensiero di Graziani si radicalizza. Lo testimoniano le revisioni, dalla terza in poi, del suo magistrale manuale che ora prende il nome di Teoria economica: il primo volume si intitola Prezzi e distribuzione e non Microeconomia; il secondo volume più tradizionalmente Macroeconomia, ma ha un contenuto fortemente innovativo. Graziani vede il processo capitalistico come una sequenza di fasi concatenate in cui il flusso e il riflusso della circolazione monetaria segna in profondità la produzione reale. L’approccio nasce quando il keynesismo dominante viene attaccato da monetarismo e nuova macroeconomia classica, ‘da destra’, e da neoricardismo e marxismo, ‘da sinistra’. Il circuitismo di Graziani è peraltro irriducibile a semplice variante della galassia eterodossa keynesiana. Si costituisce anzi a partire da una critica della Teoria generale, mentre rivaluta il Trattato sulla moneta che discende da Wicksell e Schumpeter. Se non si capisce la natura costitutiva e fondante della critica al postkeynesismo e al neoricardismo, credo che di Graziani si perda il contributo più originale.
Il discrimine tra ortodossia e eterodossia si gioca sul riconoscimento della natura macro-monetaria e di classe del processo capitalistico, che orienta anche la rilettura della teoria del valore-lavoro di Marx. La moneta è strumento di potere della classe capitalistica. Il processo di immissione, circolazione, distruzione va in prima battuta studiato astraendo dallo Stato. Si introduce però, la cruciale distinzione tra settore delle banche e settore delle imprese. Le banche finanziano il monte salari erogato dalle imprese al lavoro salariato, ed è questo finanziamento iniziale alla produzione che apre il circuito. L’offerta di moneta è dunque flusso endogeno, non stock esogeno. La non chiusura del circuito per un aumento della domanda di moneta come riserva di valore costituisce un caso particolare. Graziani è però interessato al caso generale, alla ‘moneta ‘enza crisi’.
Il rapporto tra banche e imprese definisce non solo il livello ma anche la composizione della produzione e la distribuzione del reddito. Saltano la priorità dei depositi rispetto agli impieghi e la priorità dei risparmi sugli investimenti, che vengono invertite. L’inflazione è vista soprattutto come una variazione dei prezzi relativi che determina ‘compressione’ del potere d’acquisto, tanto dei salariati come delle imprese sfavorite nella concorrenza, e può essere funzionale all’accumulazione. Il nesso tra inflazione e moneta bancaria consente di studiare come l’aumento dei prezzi muti non solo il rapporto tra le frazioni del capitale industriale ma anche quello tra imprese banche. L’inflazione degli anni Settanta ha consentito di nascondere una quota significativa del plusvalore nelle banche: gli allarmi per la compressione dei profitti industriali sono stati sfruttati per favorire una profonda ristrutturazione industriale, e conseguente ‘normalizzazione’ sociale.
Se introduciamo lo Stato, la moneta si conferma come un debito al sistema bancario, che fa perno sulla Banca Centrale. È ora possibile che i profitti, come gli interessi, siano realizzati in moneta grazie ad una immissione aggiuntiva di liquidità che finanzia quelle che Kalecki denominava esportazioni ‘interne’, ovvero i disavanzi dello Stato finanziati dall’istituto di emissione. Si spiega così come i disavanzi statali degli anni Ottanta abbiano favorito la razionalizzazione delle imprese contro il lavoro: provvedendo moneta ‘gratis’ alle imprese, e favorendo la loro disintermediazione dalle banche.
L’accesso privilegiato alla moneta è prerogativa anche dei governi: Graziani non ha mai ceduto però a illusioni ‘sovraniste’, e si è ben guardato dal farsi fautore di un aumento generico della domanda. I fallimenti del sistema privato sono profondi, e i bisogni collettivi insoddisfatti: le spesa vanno indirizzate ad una composizione del prodotto che sia socialmente utile. Lo Stato deve assicurare ai cittadini, ‘in natura’, la disponibilità reale di beni e servizi, andando al di là di una politica di sussidi monetari o di tagli fiscali. Per ultimo ma non da ultimo, lo Stato ha la responsabilità di aprire la strada ad un investimento che migliori la qualità strutturale dell’economia in un orizzonte di lungo periodo che solo lui può garantire. L’insistenza sul comando sul ‘quanto’, ‘cosa’, ‘come’ e ‘per chi’ produrre parla ai nostri giorni, dove massima è l’urgenza di una socializzazione dell’investimento. Un bisogno vieppiù radicalizzato dalla pandemia, a cui si dovrebbe rispondere con una economia sociale della produzione.
Vi è chi ha parlato di obsolescenza della teoria del circuito nel ‘nuovo’ capitalismo dopo gli anni Novanta. A torto: Graziani aveva segnalato come l’indebitamento delle famiglie ai fini del consumo configurasse non una rottura ma una ridefinizione del circuito. Nel capitalismo della sussunzione reale del lavoro e delle famiglie alla finanza e al debito le imprese ottengono ormai l’equivalente del finanziamento alla produzione ‘per via indiretta’. Una configurazione del capitalismo che altrove ho definito una sorta di paradossale ‘keynesismo privatizzato’, e di cui viviamo la crisi. Graziani aveva anche tempestivamente individuato le contraddizioni del processo di unificazione monetaria. Sosteneva però che nulla garantisce che l’uscita da un sistema di cambi fissi non si accompagni a un giro di vite nelle politiche di austerità. Una svalutazione prolungata può avere, come ha avuto, effetti deleteri se non è accompagnata da politiche strutturali, tanto più in un paese come l’Italia, caratterizzato da squilibri regionali profondi.
Il processo di sviluppo di Graziani è non soltanto un mondo di carenze di domanda effettiva e presenza di disoccupazione involontaria. È soprattutto una realtà abitata dal potere e dal conflitto, da rendimenti crescenti e diseconomie esterne, da concentrazioni regionali e da diseguaglianze che si acuiscono. Un universo dove solo l’intervento pubblico e la lotta sociale, se si sostengono a vicenda, sono in grado di incidere, sia pur lentamente e con fatica, sull’evolversi della struttura produttiva. Qui, ben oltre Keynes, contano Kalecki e Schumpeter. Graziani è, certo, un economista ‘inattuale’, ma nel senso di Nietzsche: ha cioè pensato e agito contro il tempo e, in questo modo, sul tempo e, speriamo, a favore di un tempo a venire.
Il testo che qui si pubblica è una versione modificata e aggiornata di un ricordo pubblicato su sbilanciamoci.info il 20 gennaio 2014.