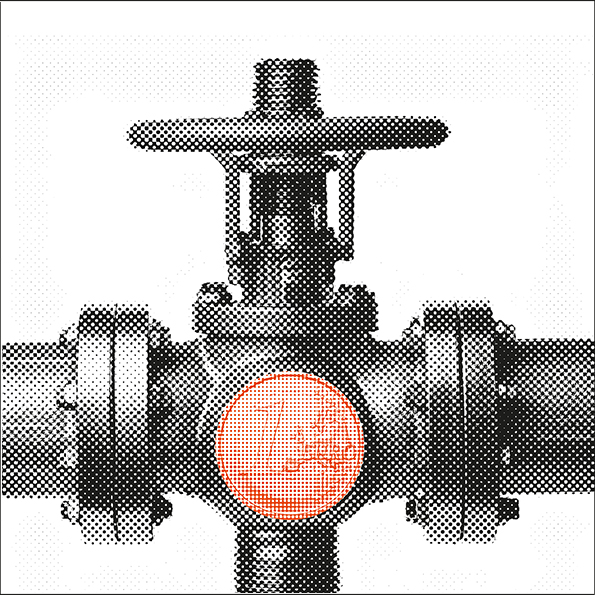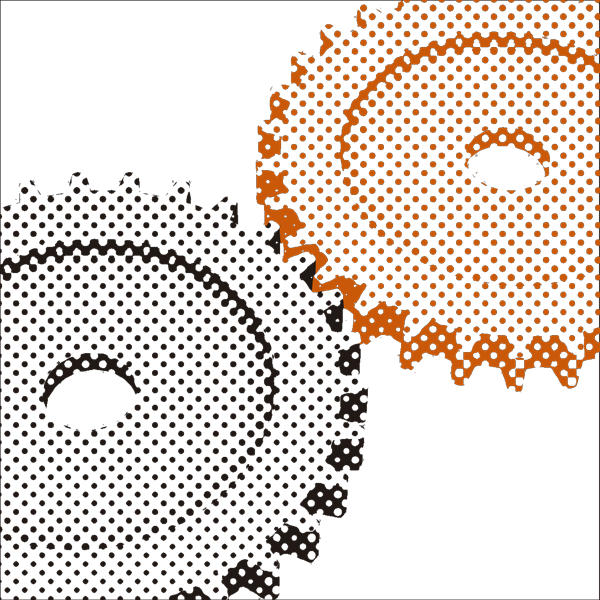La mia frequentazione scientifica di Augusto Graziani ebbe inizio nelle aule del Centro di Specializzazione post-universitario di Portici, dove fui studente del corso di Microeconomia da lui tenuto. Nei decenni successivi le occasioni di incontro con lui sono state tante; il che mi ha consentito di seguire da vicino l’evoluzione del suo pensiero. Fin dai primissimi anni ’70, Graziani andava sviluppando un percorso scientifico di radicalizzazione della visione keynesiana dell’economia. Da giovanissimo economista, da un anno ‘contrattista quadriennale nel Dipartimento di Economia di Napoli, mi ero cimentato in un’interpretazione della dinamica economica italiana imperniata sui modelli keynesiani di lungo periodo (L’accumulazione in Italia (1959-1972), De Donato, Bari, 1976). Il distacco di Graziani dal modello macroeconomico tradizionale ebbe un impatto non solo in ambito teorico ma anche in quello dell’analisi economica applicata, influenzando in profondità la sua visione dello sviluppo economico italiano. Per me costituì un importante stimolo ad approfondire lo studio del pensiero di Keynes, andando oltre la visione neo-keynesiana di cui era impregnata la struttura analitica del mio libro. Mi sollecitò infatti a mettere in discussione la vulgata keynesiana, dedicandomi alla lettura diretta degli scritti di Keynes.
Non affrontai solo lo studio della Teoria generale – molto più arduo di quanto mi aspettassi – ma anche delle altre sue opere, che non avevano trovato accoglienza in quella ‘rilettura’ della sua visione macroeconomica – riduzionistica fino al travisamento – che fu il modello IS-LM. Parlo naturalmente innanzitutto del Trattato sulla moneta, e dello scritto Teoria monetaria della produzione, che contengono in nuce la convinzione che Keynes aveva coltivando negli anni ’30 dell’alterità di un’economia monetaria rispetto alla ‘neutralità della moneta’ della visione dell’economia contenuta nel modello di equilibrio economico generale; ma anche degli articoli del ’37 sul ruolo fondamentale del credito bancario nel finanziamento della produzione; e dei suoi lavori a cavallo fra storia, politica ed economia, come Le conseguenze economiche della pace, La riforma monetaria, Esortazioni e profezie, Lassez-faire e comunismo. La riflessione su tutti questi testi fu per me di grande giovamento. Compresi quanto grande fosse la distanza del pensiero di Keynes dai cosiddetti modelli keynesiani della ‘sintesi neoclassica’.
Gli scritti di Graziani contribuirono poi ad illuminarmi su quanto eterodossa fosse la concezione del funzionamento del sistema economico che Keynes aveva sviluppato nei suoi lavori; e di come la sua eterodossia fosse stata accuratamente occultata dalla tradizione di pensiero keynesiana. Nella Teoria generale, la moneta è al centro della scena perché rappresenta il legame tra il presente e il futuro. Le aspettative riguardo alla redditività degli investimenti produttivi (EMC) e delle attività finanziarie (i) sono dominate dall’incertezza. Le aspettative vengono determinate nel breve periodo, ma al contempo influenzano il lungo periodo in quanto presiedono all’accrescimento del capitale.
Negli ultimi decenni del secolo scorso, feci parte del gruppo di giovani economisti che periodicamente si riunivano con Graziani per discutere assieme i loro lavori teorici. Il tema unificante era l’elaborazione da lui avviata della visione di ‘circuito monetario’. Confesso che i nessi fra la mia ricezione dell’analisi economica contenuta delle opere di Keynes e le idee che Graziani ci esponeva nel corso di queste riunioni non sempre mi risultavano del tutto chiari. Come è noto, lo schema del «circuito monetario» descrive una «economia monetaria di produzione» avendo come punto di partenza la creazione di moneta sotto forma di credito bancario concesso dalle banche alle imprese, che utilizzano la moneta per pagare il lavoro dei salariati, i quali provvedono all’acquisto della produzione. Il circuito si chiude quando la produzione viene acquistata, sicché le imprese, possono effettuare la restituzione della moneta alle banche. Il ‘circuito monetario’ è quindi un approccio teorico che non dà peso agli stock e concentra l’attenzione sui flussi di reddito fra imprese e lavoratori. Va ricordato che gli economisti neo-keynesiani, fra i quali il futuro premio Nobel James Tobin, nel loro tentativo di strappare ai neoclassici l’egemonia sulla macroeconomia, si erano impegnati nell’inserire il modello IS-LM in un impianto modellistico di equilibrio economico generale, nel quale risultava centrale il nesso stock-flussi. La domanda che in quelle riunioni era ricorrente nella mia mente è dunque abbastanza rilevante: com’è possibile che la visione del ‘circuito’ ridimensioni a tal punto il problema delle determinanti dell’accumulazione di capitale, ovvero della dipendenza dell’attività di investimento dalla redditività dello stock di capitale, fino a concentrare l’attenzione unicamente sui flussi monetari?
Il programma scientifico di Tobin mirava a non rompere del tutto i ponti con la tradizione dell’economia ortodossa. Nella funzione di produzione neoclassica l’impresa determina lo stock ottimo di capitale eguagliando – attraverso Il flusso di nuovo investimento – la produttività marginale del capitale al suo costo marginale di produzione. Nel modello macroeconomico di Tobin, le decisioni di investimento rispondono alla cosiddetta ‘teoria q di Tobin’. Il flusso di nuovo investimento, che va ad alimentare lo stock esistente, consiste nei beni capitali ordinati dalle imprese utilizzatrici a quelle produttrici. La domanda di investimento dipenderebbe dalle aspettative degli operatori dei mercati finanziari sul tasso di rendimento azionario. Un’impresa aumenta il proprio stock di capitale se il prezzo di domanda (il flusso di profitti attesi dall’impiego del capitale scontato al presente mediante il tasso di interesse di mercato che la quotazione di borsa dovrebbe riflettere supera il prezzo di offerta praticato dalle imprese venditrici. In altre parole, il flusso di investimento è positivo quando il rapporto q fra la quotazione di borsa dell’impresa (il prezzo di domanda dei beni capitali corrisponde al prezzo di vendita delle azioni con le quali le imprese ne finanziano l’acquisto) ed il costo di produzione del capitale ha un valore maggiore di uno.
É evidente che la distanza del ‘circuito’ dall’analisi dello schema di Tobin è enorme. Il pregio del modello di Tobin risiede nel mettere in primo piano un aspetto centrale che differenzia Keynes dall’economia neoclassica: l’autonomia decisionale che il gruppo sociale degli imprenditori riveste in un’economia monetaria di produzione. L’allontanamento di Tobin da “quello che ha veramente detto Keynes” è rilevante. Senza addentrarci nei particolari analitici, la concezione di Tobin della trasmissione della moneta all’interno del processo economico ridimensiona sia la rilevanza dell’instabilità macroeconomica che la ‘preferenza per la liquidità’, il cardine attorno al quale Keynes aveva costruito la sua critica dell’economia capitalistica, l’instabilità macroeconomica che tale sistema basato sulla proprietà privata dei mezzi di produzione minaccia di continuo di innescare e la sostanziale ineliminabilità della disoccupazione.
Il messaggio di Keynes sul ruolo del tasso di interesse come espressione della ‘preferenza per la liquidità’ si connette infatti strettamente al giudizio sulla fragilità delle basi del capitalismo. L’interdipendenza che caratterizza le aspettative nei mercati finanziari riflette il fatto che crescita e benessere sono ostaggio di ‘convenzioni’. Nella sua analisi del ‘Beauty Contest’, Keynes espresse una forte diffidenza nei confronti dei mercati finanziari, da lui visti come poco più che un ‘casinò’. Ogni operatore finanziario prende infatti le sue decisioni sulla base di credenze di ‘secondo ordine’ (i beliefs individuali si formano in relazione alle aspettative sul comportamento, e sulle credenze, dell’intera comunità degli operatori). I prezzi delle attività finanziarie non scaturiscono da un rigoroso calcolo delle probabilità soggettive individualmente assegnate, ma dipendono dal risultato complessivo che risulta in borsa dall’incontrollabile aggregazione – operata dal mercato – degli interdipendenti comportamenti dei soggetti. Il risultato, la struttura dei tassi di interesse, ha dunque una natura non deterministica ma puramente convenzionale. La definizione di Keynes della propensione all’hoarding come perverso ‘amore per il danaro’, grave ostacolo all’accumulazione di capitale, e quindi alla riduzione del rendimento del capitale fino a pervenire all’eutanasia del rentier da lui auspicata, aveva un carattere dirompente. Di essa, nella concezione della macroeconomia di Tobin, rimaneva ben poco.
Nel suo modello di equilibrio generale, Tobin si limitava a sottolineare i problemi che si celano dietro il maggior grado di sostituibilità fra moneta e titoli rispetto a quello fra titoli ed azioni. C’è tuttavia un aspetto che probabilmente allontana Graziani da Keynes e lo avvicina a Tobin. Nell’adottare lo schema stock-flussi di equilibrio generale, Tobin mette sullo stesso piano il mondo delle imprese e il mondo della finanza. Nell’abbandonare la prospettiva della relazione modellistica fra stock e flussi, il ‘circuito’ di Graziani destituisce di fatto di rilevanza per l’accumulazione di capitale il rapporto fra imprese e operatori finanziari, fino a configurare quasi un’alleanza fra i due gruppi sociali. Al di là del differente schema analitico, il punto di vista di Tobin condivide con il ‘circuito monetario’ di Graziani – che prescinde, come si è ricordato, dal nesso delle decisioni delle imprese con lo stock di capitale finanziario – la contiguità fra i due mondi delle imprese e della finanza, in quanto alla stessa stregua contrapposti al mondo del lavoro.
La valenza politica delle idee di Keynes induce a non passare sotto silenzio l’ambiguo ruolo giocato dal keynesismo. Nell’innalzare la bandiera del ‘progressismo’, con gli annessi concetti dell’espansione della democrazia dei diritti e dell’inclusione sociale, i presidenti democratici statunitensi e i primi ministri europei democristiani e social-democratici sono stati affiancati da un folto numero di economisti neo-keynesiani. La fumosa ‘terza via’ fra capitalismo e socialismo delineata dai ‘progressisti’ ha facilitato il cammino del pensiero neoliberista verso il predominio culturale nei paesi avanzati. dell’Occidente. L’idea del trickle-down e le politiche dell’austerità hanno finito per consolidare l’incremento della diseguaglianza di ricchezza e di reddito causata dal mercato, in particolare dalla deregolamentazione del mercato del lavoro. Per fare solo un esempio, il premio Nobel 2008 per l’economia Paul Krugman, in un articolo del 1997 sulla rivista ≪Slate≫ dal titolo In Praise of Cheap Labour, sosteneva che i movimenti anti-globalizzazione non volevano comprendere che ≪bad jobs at bad wages are better than no jobs at all≫. Un modo astuto di argomentare a favore della ≪visione Tina≫, there is no alternative, bandiera del neoliberismo.
In definitiva, i dubbi che mi sorgevano nel corso degli incontri di ricerca guidati da Graziani trovano soluzione una volta che si individui come caratteristica fondamentale del ‘circuito monetario’ l’analisi dei ruoli che nel capitalismo hanno i tre gruppi di agenti: le banche, le imprese, i lavoratori. Un aspetto centrale del ‘circuito’ è quello di stabilire una sequenza di comportamenti economici che vede in posizione di comando banche e imprese, mentre in posizione subordinata compaiono i salariati. Rivisitando la centralità che Keynes attribuisce all’’economia monetaria di produzione’, con la sua visione di ‘circuito’ Graziani configura una precisa concezione politica del sistema economico capitalistico. In altre parole, le relazioni di classi che hanno luogo nel capitalismo vengono presentate sotto forma di relazioni economiche fra tre aggregati di soggetti. All’analisi macroeconomica viene dato il primato rispetto a quella dei comportamenti individuali.
Dal momento che le relazioni ‘interne’ ai tre gruppi – i comportamenti individuali dei soggetti che li compongono – non hanno rilevanza alcuna dal punto di vista della società e della politica, analizzare nell’analisi per aggregati del ‘circuito’ eventuali conflitti inter-gruppo risulta irrilevante. Ad autorizzare questa interpretazione è anche l’assenza, nel ‘circuito’ di Graziani, di ogni riferimento al moltiplicatore del reddito. Pur riguardando congiuntamente le decisioni del gruppo delle imprese e quelle dei lavoratori, la dinamica economica sottesa al ‘moltiplicatore del reddito’ non presenta aspetti di conflittualità. : Pertanto, nel ‘circuito’ descritto da Graziani l’aggregazione delle decisioni di produzione e di occupazione degli imprenditori portano immediatamente ai livelli aggregati di produzione e di occupazione.
L’assenza di potere che nel ‘circuito’ caratterizza il comportamento del gruppo dei lavoratori rende lo schema di Graziani vicino all’analisi di Michał Kalecki. La concezione della macroeconomia proposta dall’economista polacco è anch’essa ispirata al confronto fra gruppi sociali. Il grado di potere nell’economia di capitalisti e lavoratori talmente è fortemente divaricato. Kalecki mostra infatti come nel sistema i capitalisti (banche e imprenditori) guadagnano ciò che spendono e i lavoratori salariati spendono ciò che guadagnano, sicché i profitti sono strettamente proporzionali al livello della produzione.
Il decennio in cui Graziani iniziò ad elaborare il suo ‘circuito monetario’ seguì quello che si aprì con la pubblicazione di “Produzione di merci a mezzo di merci”, lavoro nel quale Piero Sraffa espose la sua critica all’economia marginalista. Il messaggio politico con il quale venne divulgato il modello elaborato da Sraffa era semplice: una volta depurata dal marginalismo, l’analisi microeconomica mette capo ad una distribuzione del Pil – determinato in base al livello di occupazione individuato dal modello macroeconomico di Keynes – fra i due gruppi sociali fondamentali dei capitalisti e dei salariati. Data la gerarchia di potere tipica del capitalismo, è il saggio di profitto a fungere da variabile indipendente.
In decenni ormai passati, i due modelli del ‘circuito monetario’ e di “Produzione di merci a mezzo di merci” apparvero – rispettivamente ai seguaci dell’una o dell’altra delle due ‘chiese’ di teoria economica eterodossa – come il ‘diavolo e l’acqua santa’. In particolare, il primo, pur denunciando l’origine nello squilibrio di potere politico vigente nella società capitalistica, era gravato dal limite, ereditato da Keynes, veniva imputato di non rescindere fino in fondo il cordone ombelicale con il modello neoclassico. Del secondo, benché sottolineasse l’autonomia della produzione nella fissazione del saggio di profitto, si lamentava una visione eccessivamente economicistica della separazione fra livello del reddito e sua distribuzione.
Oggi, le cose sono notevolmente cambiate. Il capitalismo ha rinunciato al paludamento del rigore scientifico. La sua interpretazione in base al concetto di economia monetaria – dopo essere andata avanti a slogan, dal ‘whatever it takes’ alle sottigliezze verbali, ormai spoglie di contenuti di teoria monetaria, degli annunci della Lagarde su tassi di interesse e di inflazione futuri – sembra avere abbandonato il convenzionalismo per arrendersi al dominio della politica. I potenti della terra, politici-tycoon e tecno-manager, dopo aver lasciato cadere ogni mascheramento della loro volontà di decidere in autonomia i destini del pianeta, per non incontrare ostacoli al loro dominio sono sempre più inclini ad affidarsi al travisamento della verità. Contestualmente all’arretramento economico della classe media, nei paesi avanzati occidentali si è registrato anche un indebolimento del controllo della democrazia politica. In nome del proprio potere assoluto, conquistato con maggioranze di voto favorite da ingenti finanziamenti alle campagne elettorali, i rappresentanti del potere economico capitalistico hanno in grande dispregio non solo il benessere ma la stessa dignità del crescente numero dei ‘senza potere’. Nel mondo di oggi la politica e l’economia fanno dunque un tutt’uno. E i dibattiti di principio di un tempo appaiono come ispirati ad un’ingenua fiducia, ormai tramontata, nel mondo delle idee.